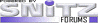|
|
| Autore |
 Discussione Discussione  |
|
|
Ermanno2
 
Regione: Calabria
Prov.: Cosenza
Città : S.Agata d'Esaro

62 Messaggi |
 Inserito il - 06/07/2010 : 08:26:25 (5404) Inserito il - 06/07/2010 : 08:26:25 (5404)



|
Era il 1975 quando Pier Paolo Pasolini scriveva un articolo sulla scomparsa delle lucciole.
Nei primi anni sessanta a causa dell’inquinamento dell’aria e soprattutto in campagna a causa dell’inquinamento dell’acqua (gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti) sono cominciate a scomparire le lucciole, il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo anni le lucciole non c’erano più, sono ormai un ricordo abbastanza straziante del passato.
Le lucciole (classe: insetti; ordine: coleotteri; famiglia: lampiridi) presentano all’interno del loro corpo un enzima chiamato luciferasi che agendo su un substrato chimico, la luciferina, produce bioluminescenza. Questa luce intermittente naturale, viene usata dalle lucciole nelle “parate sessuali”.
Nelle lucciole marine del genere “ Odontosyllis” l’accoppiamento avviene con la luna piena cinquantacinque minuti dopo il tramonto. Le femmine che si distinguono dai maschi per un aspetto più simile ad una larva e per due segmenti luminescenti anziché tre, vengono in superficie e nuotano rapidamente descrivendo dei cerchi, ed emettendo una viva luminescenza che ha la foggia di un alone.
A questo punto i maschi risalgono dal fondo del mare emettendo anch’essi una luce sottoforma di piccoli lampi e dirigendosi con precisione verso il centro dell’alone, volteggiando assieme alle femmine per qualche istante, liberano un essudato luminoso, poi la luce scompare bruscamente.
La femmina di lucciola del genere Photuris, risponde ai bagliori del maschio in volo, dopo una conversazione luminosa i due amanti si accoppiano; a questo punto la femmina emette dei lampi di luce identici a quelli di un altro genere attraendo con l’inganno i maschi che posandosi vicino a lei vengono divorati.
Pasolini nell’articolo delle lucciole crea una interessante analogia tra questi insetti ed il genere umano.
L’uomo della società contemporanea è stato vinto ed annientato come una lucciola trafitta da uno spillo, seccato dalla luce artificiale e feroce dei riflettori, dall’occhio indiscreto delle telecamere di sorveglianza e dall’agitazione mortifera degli schermi e dei palcoscenici televisivi; i riflettori delle torri di guardia, degli spettacoli politici, degli stadi di calcio.
La televisione, non solo non concorre ad elevare il livello culturale degli strati umani inferiori, ma determina in loro un senso di inferiorità angosciosa, in quest’epoca di dittatura industriale e di consumismo l’uomo qualunque finisce per esibirsi come una merce nella sua vetrina, così appunto da “non apparire”.
Le massificazioni culturali e commerciali, le volgarizzazioni della realtà, le industrie culturali si sono appropriate dei corpi, dell’eros, inserendoli così nel circuito del consumo.
Ma la cosa peggiore consiste nel fatto che tutti appaiono soddisfatti in questa società, tutti hanno l’aria appagata di chi crede di potersi rifare una nuova bellezza, profittando di questa trionfale industria dell’esposizione politica.
Ci sono solo segni da brandire e nessun segnale da trasmettere e da scambiarsi. Non c’è più nulla da vedere o da pensare, non esistono più esseri umani ma macchine.
Nelle parole di Pasolini riusciamo a carpire una totale forma di pessimismo nei confronti dell’uomo moderno e della società attuale, ma a parere di Georges Didi-Huberman bisogna pur sempre dare un barlume di speranza alla nostra vita, in modo che il Già-stato incontri l’Adesso per dare origine ad un bagliore, ad un lampo, ad una costellazione.
Benchè rimangono quasi rasoterra, benché emettano una luce debolissima, benché si spostino lentamente, le lucciole disegnano una costellazione di questo genere.
L’immaginazione, questo lavoro che produce immagini per il nostro pensiero, ci illumina attraverso il modo in cui il Gia-stato e l’Adesso si incontrano per far nascere costellazioni ricche di Futuro. Tutto questo ci porta a capire quanto sia importante e decisivo questo incontro dei tempi, questa conflagrazione di un presente attivo con il suo passato reminiscente.
Giorgio Agamben, è un filosofo dei paradigmi, gli oggetti più comuni, le immagini più disparate oltre ai testi canonici che egli non smette di commentare e discutere, divengono per lui l’occasione di una “epistemologia dell’esempio”, di una vera e propria archeologia filosofica.
Agamben affronta la contemporaneità che è per lui ciò che appare “nella sfasatura e nell’anacronismo” rispetto a ciò che percepiamo come la nostra attualità. Accogliendo il paradigma che qui ci interessa significherebbe darsi gli strumenti necessari per vedere le lucciole; questo però richiede coraggio, virtù politica e poesia che è l’arte di fratturare il linguaggio, di infrangere le apparenze, di smontare l’unità di tempo.
Il primo libro di Giorgio Agamben, a riguardare esplicitamente la questione della storia, inscriveva nel titolo stesso la parola “distruzione” : Ogni discorso sull’esperienza deve oggi partire dalla constatazione che essa non è più qualcosa che ci sia ancora dato di fare.
Poiché, così come è stato privato della sua biografia, l’uomo contemporaneo è stato espropriato della sua esperienza: anzi, l’incapacità di fare e trasmettere esperienze, è, forse uno dei pochi dati certi di cui egli disponga su se stesso.
A confermare questa teoria sta il fatto che l’uomo, non si era accorto che dopo la fine delle guerre, la gente tornava ammutolita, non più ricca ma più povera di esperienze comunicabili. E ciò non stupisce. Poiché, mai esperienze furono più radicalmente smentite di quelle strategiche dalla guerra di posizione, di quelle economiche dall’inflazione, di quelle fisiche dalle battaglie caratterizzate da un grande dispiego di mezzi e materiali, di quelle morali dai detentori del potere.
Per Agamben quindi, l’immagine non è l’apertura ed il limite stesso della sua apertura che ne definisce sia progresso infinito che eterna attesa, non è neanche l’orizzonte, che ci promette l’immensa luce lontana costantemente celata dietro la sua grande linea di fuga , ma è quell’esperienza che si caratterizza per la sua intermittenza, la sua fragilità, la sua frequenza di apparizioni, di sparizioni, di incessanti riapparizioni e risparizioni.
Davanti ad una immagine, non ci si potrà cullare a lungo nelle illusioni, perché essa scomparirà presto, l’immagine è così un incidente del tempo che la rende momentaneamente visibile o leggibile. L’immagine che è un regime empirico di approccio ed avvicinamento, serve a liberare lo spazio immenso dell’orizzonte, che è il regime del lontano, dell’apogeo, dell’assoluto.
Le immagini di oggi, vengono ridotte da Agamben a: “forme mediatiche dell’immagine”; queste assumono nel mondo contemporaneo la funzione di una “gloria” legata alla macchina del “regno”, immagini luminose che, con la loro forza, contribuiscono a fare di noi dei popoli “asserviti” ipnotizzati nel loro flusso. Ciò corrisponde alle sensazioni di soffocamento e di angoscia da cui siamo colti davanti alla deliberata proliferazione delle immagini, utilizzate come veicoli sia della propaganda, sia della merce.
Tutto ciò produce falsi saperi, ed è tutto ciò che l’idealismo filosofico oppone tradizionalmente all’ Epistème, la vera conoscenza, la scienza intellegibile, la capacità di cogliere le idee giuste.
Scrive Agamben: “ il paradigma è un caso singolo che viene isolato dal contesto di cui fa parte, rende intellegibile un nuovo insieme, la cui omogeneità è esso stesso a costruire. Il paradigma senza uscire dalla singolarità, trasforma in ogni singolo caso un esemplare di una regola generale che non è mai possibile formulare a priori. Il Paradigma oggi ha perduto la sua potenza primordiale e fondamentale: “l’acclamazione”.
Concentrare il nostro sguardo sull’orizzonte, corrisponde quindi a non cogliere le immagini che da vicino giungono a sfiorarci, e sono proprio queste immagini fragili ed intermittenti a prendere forza e potenza in questa insospettata carica di vita che si dimostra nella loro capacità di riapparire e sopravvivere, di una sopravvivenza intesa come vita dopo la morte, sopravvivenza da apocalisse, da redenzione pura.
Le immagini, vanno intese nella loro immanenza fondamentale: né il loro nulla, né la loro pienezza, né la loro origine precedente ad ogni memoria, né il loro orizzonte successivo ad ogni catastrofe; ma la loro risorsa di desiderio ed esperienza nel cuore delle nostre decisioni più immediate della nostra vita più ordinaria.
Affermarlo nel minuscolo esempio delle lucciole, significa affermare che nel nostro modo di immaginare si trova fondamentalmente una condizione del nostro modo di fare politica. L’immaginazione è politica, ecco ciò di cui dobbiamo prendere atto. Viceversa, la politica non può esistere in un momento o in un altro senza la facoltà di immaginare.
In base alle teorie esposte, siamo obbligati a ricrederci sul pessimismo esasperato di Pasolini, il vero pessimismo risiede nell’apatia, nell’indifferenza, e nell’incapacità di comunicare e trasmettere pensieri.
Se trova le condizioni, per quanto fragili della sua narrazione e della sua trasmissione, il “pessimismo” qualche volta viene “organizzato” fino a produrre, nel suo stesso esercizio, il barlume e la speranza intermittenti delle lucciole.
Nella “Sequenza del fiore di carta”, Pasolini esprime il suo concetto sull’innocenza:
“L’innocenza è una colpa, l’innocenza è una colpa, lo capisci? E gli innocenti saranno condannati, perché non hanno più il diritto di esserlo. Io non posso perdonare chi passa con lo sguardo felice dell’innocente tra le ingiustizie e le guerre, tra gli orrori e il sangue. Come te ci sono milioni di innocenti in tutto il mondo, che vogliono scomparire dalla storia piuttosto che perdere la loro innocenza. E io devo far morire, anche se lo so che non possono far altro, io debbo maledirli come il fico, e farli morire, morire, morire…”.
Bisogna così almeno riconoscere l’essenziale vitalità della sopravvivenza e della memoria quando esse trovano le forme giuste per la sua trasmissione, che si sprigionerà in questa combinazione geometrica tra il ritirarsi e il non piegarsi, che Hannah Arendt definisce “forza diagonale”: due forze contrastanti, sono illimitate nel senso dell’origine, in quanto provenienti l’una da un passato infinito e l’altra da un infinito futuro; però se manca di un principio conosciuto, hanno entrambe un punto terminale, quello in cui si scontrano.
La forza diagonale invece avrebbe un limite nel senso dell’origine (il punto di scontro tra le due forze contrastanti) ma sarebbe illimitata nel senso opposto, essendo la risultante di due forze dall’origine infinita. Questa forza diagonale, avendo una origine nota, una direzione determinata dal passato e dal futuro, ma un termine illimitato, è l’immagine perfetta dell’attività del pensiero.
Sarebbe questa in conclusione l’infinita risorsa delle lucciole: il loro ritirarsi quando è forza diagonale e non un ripiegarsi su se stesse. La loro comunità clandestina di “scintille di umanità” quei segnali inviati per intermittenze, la loro essenziale libertà di movimento, il ritirarsi che non sia ripiegamento su noi stessi, la facoltà di fare apparire scintille di umanità, il desiderio indistruttibile.
Noi stessi, in disparte rispetto al regno ed alla gloria, nella lacuna aperta tra il passato e il futuro, dobbiamo quindi trasformarci in lucciole e riformare, così una comunità del desiderio, una comunità di bagliori, di danze malgrado tutto, di pensieri da trasmettere.
Noi oggi non viviamo in un mondo, ma tra due mondi: il primo è inondato di luce, il secondo attraversato da barlumi. Al centro della luce si agitano le “stars”, le stelle, che come sappiamo portano nomi di divinità, sui quali traboccano informazioni il più delle volte inutili; ma ai margini, avanzano molti popoli sui quali sappiamo troppo poco, popoli-lucciole che si ritirano nel buio della notte per la loro voglia di libertà di movimento, “fuggono ai riflettori del regno”, fanno di tutto per affermare i loro desideri, i loro lampi di luce e indirizzarli ad altri.
Ma un popolo anche se pur sempre sconosciuto è una entità esistente che si rafforza solo quando è unito. Solo il popolo effettivamente riunito può fare ciò che è specificatamente proprio dell’attività di questo popolo: esso può acclamare…..
Se appena il popolo è effettivamente riunito, non importa a quale scopo, nelle feste pubbliche, nei teatri, all’ippodromo, allo stadio, questo popolo acclamante è presente, ed è almeno potenzialmente una grandezza politica. L’opinione pubblica è la forma moderna dell’acclamazione e non c’è nessuna democrazia e nessuno Stato senza opinione pubblica, come non c’è nessuno Stato senza acclamazione.
|
|
| |
 Discussione Discussione  |
|
|
|
| Santagataviva2004 Forum |
© Santagataviva2004 |
 |
|
| Questa pagina � stata generata in 0,13 secondi. |
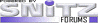 |
|